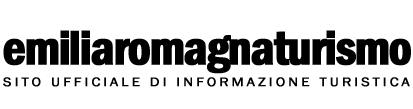È nel cuore di ogni cittadino di Ravenna come solo può esserlo il vecchio fienile per un montanaro o l’angusta sottocoperta per il marinaio: è il Capanno da Pesca, piccolo e ameno luogo di pace e relax, a contatto diretto con la natura, e soprattutto garanzia di conviviale allegria per i fine settimana e il tempo libero.
Da tempo non se ne costruiscono di nuovi, né tantomeno se ne vendono. Quelli ancora esistenti rappresentano un piccolo tesoro di cui andare fieri e gelosi.

Si dice che l’origine del capanno, detto anche Padellone (o Bilancione), per via della grande rete protesa sull’acqua, risalga al XV secolo, ma è nell’800 che ne viene documentata la diffusione nell’area del Delta del Po e lungo la tutta la costa adriatica.
La struttura del capanno – come indica la denominazione stessa – è quella di un casotto costruito in parte sulla terraferma, in parte appoggiato su una chiatta o su una palafitta sospesa sull’acqua.
La sua funzione originaria è quella di offrire un ricovero temporaneo per l’attività della pesca. Subito attigua al capanno vi è infatti montata una grossa rete quadrata (padellone) che viene calata in acqua a raccogliere il meglio del pesce azzurro.
Il materiale di costruzione è sempre stato povero, di scarto. Chi aveva una porta o un telaio di una finestra in più, sapeva come riciclarli.
Al suo interno il capanno ha uno o due locali, con una zona per cucinare e mangiare, l’altra per riposare all’occorrenza.

L’attività di pesca è oggi minuziosamente regolamentata, i capanni che la effettuano sono quindi in possesso di specifiche licenze e sono soggetti a controlli da parte delle autorità competenti in materia.
Questo, insieme alla manutenzione, rende i costi di gestione non indifferenti. Di solito, infatti, i capanni sono in concessione a società di gestione organizzate in quote, che possono essere cedute con il diritto di prelazione e trasmesse per eredità.
Ogni socio è responsabile per onori e oneri della sua quota e a legarli insieme è poco più che un patto tra gentiluomini: lunedì a te, mercoledì a me, a chi tocca il sabato spetta anche la domenica. Insieme, di fatto, i capanni tramandano la cultura dell’acqua tra mare, valli, lagune, piallasse, fiumi e canali.
All’alba o al tramonto, nelle giornate di nuvole o sole, assistere allo spettacolo delle reti che salgono, con i pescatori che vi lavorano attorno, regala uno spettacolo unico.
Così, per l’escursionista che avanza tra uno specchio d’acqua, la macchia di giunchi e uno stormo di fenicotteri rosa che s’alza in volo, la vista di una fila capanni da pesca con la rete a mezz’asta acquista il sapore di un racconto d’avventura.
Oltre a costituire un insolito skyline nel cuore di una natura selvaggia, il richiamo immediato a storie di altri tempi e a grandi imprese sportive è infatti forte ed emozionante.
Storie che celebrano quello stesso binomio uomo-natura, solido e misterioso, descritto da Eugenio Montale in “Dora Markus”, poesia ispirata da una passeggiata sulla marina ravennate:
Fu dove il ponte di legno mette a Porto Corsini sul mare alto
e rari uomini, quasi immoti, affondano o salpano le reti.
Oggi si direbbe che se l’attività di pesca è la mission del Capanno, la vision è tutto ciò che ci gira attorno. Ovvero è la magia della giornata di pesca con scommesse, commenti e confronti, e soprattutto quel che viene dopo, la condivisione del pescato cucinato sul posto con amici e famiglia.
L’antico detto “us magna cun quel che us ciapa” (ovvero si mangia quello che si prende), da queste parti, prometteva piatti a base di cefali, acquadelle, sarde, acciughe e alici, gamberetti, sogliole e anguille.
Fritti o alla brace, usati per condire la pasta o cucinare un bel risotto, magari profumato dalle erbe selvatiche, assicurano prelibatezze dal sapore autentico. Oggigiorno il pescato è forse meno ricco, ma il gusto – assicurano i capannisti – conserva la stessa identica bontà di allora.