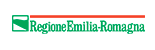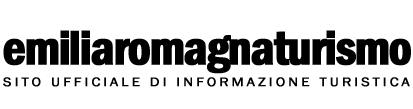La Darsena di città fu, almeno fino alla prima metà del ‘900, il cuore pulsante dell’economia e del commercio di Ravenna. Attorno al Canale Corsini, detto Candiano, sono sorti nei decenni molti edifici produttivi che hanno dato vita a quei moli e lavoro alla città.
In gran parte dismessi con lo sviluppo del porto-canale nel secondo dopoguerra, sono da qualche lustro al centro di un’articolata operazione di recupero e rigenerazione urbana che sta vivendo in questi anni una fase di particolare intensità.
Ecco una possibile mappa di alcuni di questi luoghi, che delineano il paesaggio della Darsena e permettono di esplorare in modo diverso un luogo fondamentale della città, che può tornare ad essere spazio pubblico d’eccellenza, bene comune e bacino di comunità.
MANGIMIFICIO MARTINI
Un gigantesco murales dell’artista italiano Ericailcane occupa un’intera facciata di questo edificio, ben visibile sulla sponda settentrionale del canale. In uso fino ai primi anni 2000, venne costruito nel 1912 e fu in principio un mulino per la produzione di farine. Quasi distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, venne ricostruito negli anni ‘50 per diventare un mangimificio che arrivò ad impiegare una sessantina di dipendenti.
Al suo interno si trovano vari locali, aggiunti nei decenni, tra silos, fosse di scarico, uffici, officine, una falegnameria, cabine elettriche, fino agli alloggi per il custode e gli spogliatoi dedicati agli operai. Sgomberato definitivamente nel 2015, viene ancora in parte manutenuto, mentre le macchine funzionanti presenti all’epoca sono state ridistribuire in altri stabilimenti nella penisola.
FIORENTINA 1 E 2
Procedendo lungo la stessa banchina si incontrano due edifici attigui, costruiti tra il 1905 e il 1924. Il primo ha una struttura a graticcio, totalmente in legno, con un interno a tre navate che ricorda quello di una basilica. Questa sorta di casa a traliccio, tipica del centro e nord Europa, è un raro esempio in Italia di stile fachwerk. Sormontato fino agli anni ‘80 da una gigantesca gru, poi rimossa, venne usato dapprima come fabbrica di concimi chimici, poi come deposito. I danni provocati dalla pesante ondata di maltempo del 2017 hanno costretto ad una bonifica dell’immobile che oggi si presenta con il telaio completamente a nudo.
Pochi metri oltre si trova un fabbricato molto curioso, un tempo adibito alla produzione di acido solforico. Ricostruito in gran parte nel dopoguerra sulla base di un altro stabile, di una trentina di anni più vecchio, venne poi abbandonato negli anni ‘50 a causa della diffusione di nuovi impianti similari, dotati di sistemi più moderni. La peculiare suddivisione in livelli di cemento armato, senza solai, con la presenza di 19 telai in legno lo rendono, in Italia, quasi unico nel suo genere.
SEDE STORICA TIRO A SEGNO NAZIONALE
Quasi 21.000 mq di campo di tiro contraddistinguono questo antico edificio, adibito a tiro a segno, costruito alla fine dell’800 con una delle prime strutture italiane di calcestruzzo armato.
Danneggiato profondamente dai bombardamenti che interessarono tutta la zona del porto durante la guerra, venne abbandonato alla fine degli anni ‘70 in favore di un edificio attiguo, più adeguato alle normative vigenti.
Il complesso, chiuso da vari cancelli, è costituito da un ampio porticato sormontato da un’aquila ad ali spiegate, incastonata in un’imponente architrave. Oggi l’edificio ospita periodicamente eventi culturali, mostre, concerti e perfomance di danza e teatro.
RAFFINERIA SAROM
Michelangelo Antonioni scelse di girare proprio qui, nella cosiddetta “foresta d’acciaio”, alcune scene del suo capolavoro, Deserto Rosso. A fare da scenografia le torri di raffreddamento Hamon, sorte all’inizio degli anni ‘50, necessarie per la raffinazione in grandi quantità di olii minerali.
I serbatoi sottostanti, capaci di contenere ognuno il carico di una petroliera oceanica, erano collegati ad un’isola di attracco costruita a 6 km dalla costa, che permetteva alla enormi cisterne di operare senza doversi avvicinare al porto. Con la crisi petrolifera mondiale patita a metà degli anni ‘70, la raffineria iniziò il suo calvario, che la porterà a chiudere definitivamente nel 1981.
Nel 2024 è stata presa la decisione di abbattere le due Torri a causa delle preoccupazioni legate alla sicurezza, dovute alla loro vetustà e al cattivo stato di conservazione in cui si trovavano. Questo intervento è parte integrante del progetto per la creazione di un parco fotovoltaico volto alla produzione di energia rinnovabile.